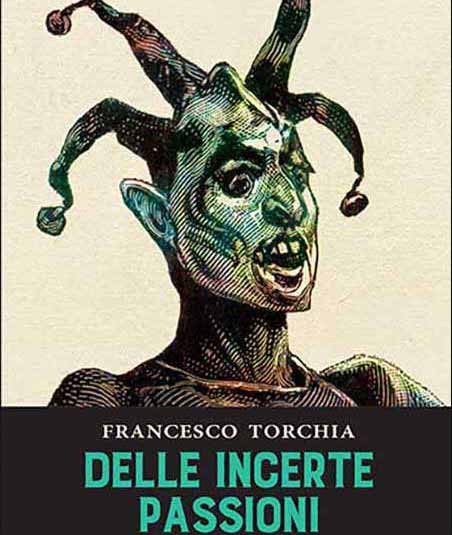La parola e la cosa
Sono qui, in questa trincea mefitica, in questa sorta di imbuto fangoso che risucchia il corpo e la mente, a scrivere con mano malferma queste brevi note, che il cuore “mi ditta dentro”, con l’affanno e l’angoscia di una notte che non porta il balsamo del riposo, ma piuttosto i singulti straziati della mia persona senza riparo e salvezza, senza approdo e quiete. Il cielo stellato sopra di me, con la sua indifferenza, con la sua limpidezza priva di conforto e di calore, è solcato di tanto in tanto da razzi bianchi che attraversano l’aria simili a comete maligne, portatrici di dolore e di morte, accompagnati nella loro scia di devastazione dal crepitio delle mitragliatrici, quasi damigelle di questo corteo assassino, con i loro proiettili miagolanti, indirizzati in ogni angolo, in ogni pertugio, per non lasciare scampo al tumulto che afferra noi soldati di questa guerra piena di rumore e di furore, che non significa nulla. Così passerà anche questa notte, con il respiro affannoso delle prede braccate nelle loro misere tane da un nemico senza volto, nell’impotente tensione di chi si abbarbica alla vita pura, senza aggettivi, senza la consistenza dell’umano, ma semplicemente e aridamente conato di sopravvivenza, di perpetuazione del nostro essere indifeso in una terra desolata, costellata dalle croci rudimentali dei nostri morti, che pietosamente seppelliamo tra loro vicini, almeno solidali nel loro ingresso nel mistero del destino ultimo, che tutti ci attende. Ma sono stato io a volere questa notte, e le altre che seguiranno, fin quando mi saranno riservate; sono qui perché non ho compreso sino in fondo il potere ammaliante della parola, e la possibilità che essa occulti la cosa che pretende di rappresentare, celandone la verità e l’essenza. Sono stato “raggirato” dalla potenza stupefacente della parola, che si libra sopra l’immensa varietà del mondo e lo incanta con il flusso del linguaggio, che irretisce chi si accosti senza avvedutezza al suo canto, come le sirene che cercarono di stregare i marinai di Ulisse. Già, una certa declinazione della parola guerra, che prima mi ha attratto e poi gettato in questa avventura senza speranza e senza gloria, non ha trovato in me la resistenza sagace di Ulisse, ma invece una docile partecipazione, una entusiastica sensazione di ebbrezza pervasa di esaltata incoscienza. E così, l’abile uso della parola, di personaggi esagitati, veri esperti dell’arte della persuasione, mi ha reso desiderabile il colore del sangue come vino dei popoli e il balenio irridente della violenza, mi ha donato un senso di poesia e un brivido di esoterico mistero nella celebrazione della prevaricazione dell’uomo sull’uomo, mi ha fatto assaporare il godimento rigenerante che solo il lavacro purificatore della guerra, unica “igiene del mondo”, può provocare. Io, appassionato lettore di Giovanni Papini, sono rimasto abbagliato dalle sue parole, quando scriveva su “Lacerba” che “la guerra è spaventosa - e appunto perché spaventosa e tremenda e terribile dobbiamo amarla con tutto il nostro cuore di maschi”. Io, studente di filosofia e ammiratore di Gabriele D’Annunzio, ero presente a Roma, il 13 maggio 1915, quando il Vate arringava il popolo romano con parole infuocate, dall’empito travolgente, incitando i cittadini alla violenza, e vantandosi di questo crimine. Possibile, allora, che i miei studi filosofici non mi avessero insegnato nulla? Eppure, avevo studiato con impegno e passione, in un corso monografico, il Gorgia di Platone, con la sua mirabile denuncia della retorica, che corrode e degrada, con il suo manto ammaliatore, con il suo conturbante coacervo di parole prive di ancoraggio alla realtà profonda delle cose, la nostra sete di verità, la nostra necessità di conciliare le parole e le cose, affinché da questa pacificazione scaturisca la gioia della conoscenza senza infingimenti e manipolazioni, inganni e travisamenti. Ero troppo inebriato da questa retorica che “colonizza” e perverte le coscienze per ascoltare il mio daimon socratico, la pacatezza della ragione che frena e ammansisce l’urgenza degli impulsi e degli istinti. Già volontario in questa guerra insensata, ancora imbevuto della promessa di eroismo consegnatami dalla mia “ubriacatura” nazionalistica, ho sorriso, sprezzante, ancora poco tempo fa, dell’invocazione di papa Benedetto XV alla cessazione immediata di una “inutile strage”. Ma il mio daimon, sfidato da questa esperienza bellica di accecante degradazione, finalmente ha fatto ascoltare la sua voce intrisa di saggezza, illuminandomi sulla cosa della guerra, che non redime un mondo sferzato dal vento lancinante del dolore, che non cancella la difficoltà del vivere, che non lava i peccati. Certo, per me è faticoso, ammantato di dolore, riconoscere il fallimento di una idea di guerra in cui ho creduto, in cui ha prevalso un amore di patria fondato essenzialmente sull’odio delle altre patrie; ma, se di amore autentico si tratta, allora esso non può significare la volontà di uccidere chi ama un’altra patria, perché amare spinge ad onorare il bene comune che alligna in tutti i popoli, purché consapevoli dell’unità profonda della propria medesima umanità. Ma saremo in grado di riconoscerci un giorno in una comune solidarietà di destino? Saremo in grado di confederare la nostra condivisa fragilità di esseri miseramente transeunti, per far valere in tal modo la grandezza del pensiero e della volontà di amare di cui siamo dotati? Queste domande sono troppo grandi, troppo impegnative per me, in questo momento: adesso, sento solo angoscia, scontentezza, spasimo; non sono in grado di immaginare il futuro o la speranza. Il mio “pensiero dominante” è quello del fragile confine, segnato da un’angosciante incertezza, che divide la morte dalla vita, quando un proiettile, nel silenzio pauroso della notte, fa sussultare la trincea e le sue schegge malvagie si spargono per ogni dove, con un movimento paragonabile a quello di coriandoli appuntiti, portatori di maleficio, mentre una polvere acre mi investe e penetra in profondità nelle mie narici. Ma voglio adoperarmi ad essere forte; primum vivere deve essere il mio motto, perché devo salvare almeno l’impalcatura della mia appartenenza all’umanità, ridotta in brandelli, devo attendere il ritorno del giorno dopo questa triste notte, ipotizzando che, prima o poi, si palesi nuovamente la luce anche per il mio essere ferito, che ancora non si rassegna a morire…
Piccole speranze
Sono ancora qui, su questa terra, aggrappato all’albero della vita, come il protagonista di Moby Dick sopravvissuto all’inabissamento del Pequod, che racconta smarrito la sua storia senza lieto fine, persa nel vortice irrimediabile dell’oceano, immenso “coperchio” dei tumulti umani, richiusi da un sigillo mortifero, sepolti irrimediabilmente dal moto infaticabile delle onde. Anch’io mi sento come un naufrago scampato al disastro di questa guerra animata da un furore assassino, che, simile ad una ondata irrefrenabile, si è propagata senza argini per l’intero corpo della terra. Quando, nei miei sonni inquieti, sono visitato dai fantasmi della notte, un’immagine ritorna insistente, tale da agghiacciare ogni fibra dell’essere: un immenso fiume, ormai straripato e senza ostacoli, tutto travolge al suo passaggio e, come l’“Arbia colorata in rosso” evocata nell’Inferno di Dante, è intinto di sangue, il sangue dell’intera umanità piagata dal morbo dell’odio e dell’insensatezza. Allora, nel momento in cui questo incomprimibile fiume di sangue è sul punto di annientarmi senza possibilità di salvezza, mi sveglio con gli occhi sbarrati e il cuore in gola, nel mio letto inospitale, privo di qualsiasi parvenza di calore. Già! Dove sono ora? Non più in una trincea dagli odori nauseanti, non più in un campo di battaglia pervaso dal fumo acre rilasciato dai proiettili maligni delle mitragliatrici, non più sotto la volta del cielo con le sue stelle silenti che, inebriate dallo splendore che promanano, si compiacciono come Narciso della loro sfavillante bellezza, senza curarsi del nostro miserevole strazio, della nostra insignificante presenza in un cosmo abitato dall’immenso, che non ci degna di compassione per la nostra piccolezza, ma piuttosto procede imperturbabile nei suoi maestosi ingranaggi senza tempo. Sono tra le pareti slabbrate, tra gli intonaci cadenti di questa grande e buia stanza d’ospedale, circondato dai lamenti strazianti dei miei commilitoni, con il volto sfigurato o gli arti amputati e il loro quotidiano confronto con un dolore privo di requie, di respiro, di pietà. Perché sono qui? Perché la vita non mi ha sottratto al suo abbraccio e non mi ha consegnato ad una tomba malferma, sotto una croce miserevole pietosamente apprestata dai miei compagni? Ho un vago ricordo di quanto mi è accaduto: le schegge malvagie di una granata mi avevano colpito e si erano conficcate nella mia carne, senza preannunciarsi, ma solo intrise della loro beffarda violenza; e io, dopo lo svenimento per un dolore senza confini, di lacerante atrocità, come una lama tagliente e infuocata che squarciasse il misero involucro del mio corpo, avevo per un momento aperto gli occhi, avvertendo la sensazione indicibile di trovarmi sulla soglia sottile che separa la vita dalla morte, ma senza angoscia, anzi quasi con la voluttà di poter sperimentare l’ingresso nel paese inesplorato da cui nessun viaggiatore ha mai fatto ritorno. Morire, dormire… pensavo in quegli istanti fugaci in cui la mia esistenza terrena si risolveva; come il principe Andrej Bolkonskij in Guerra e Pace, mi sembrava di vedere in una luce nuova il cielo altissimo che mi sovrastava, con la sua maestà altera, con le sue nuvole veleggianti dalle quali faceva capolino l’infinito colorato di azzurro. Poi… poi, più nulla, se non il doloroso risveglio in questo letto d’ospedale: la vita aveva, almeno momentaneamente, prevalso sulla morte, e il mio corpo indifeso, pur nello strazio della mia condizione, pulsava ancora del desiderio di vivere, di partecipare nuovamente all’avventura irripetibile dell’esistenza. Ma quale esistenza? Forse dovremmo vivere per glorificare la guerra, “sola igiene del mondo”, come ci ha proposto nel suo Manifesto del Futurismo Filippo Tommaso Marinetti? Dovremmo ricercare la “bella morte”, impregnati di un militarismo cieco e distruttivo, votati alla prevaricazione feroce dell’uomo sull’uomo? O piuttosto dovremmo rispondere all’appello di Romain Rolland, che ci invita ad abbattere l’odio e l’ingiustizia tra gli individui e i popoli, per edificare la cinta di una città in cui si riuniscano le anime fraterne del mondo intero, imbevute del profumo irresistibile della libertà? Già, io sono stato “irretito” dalle sirene ammalianti del bellicismo, da un patriottismo votato all’esasperazione e all’esclusione, quando sono partito da volontario per il fronte, interrompendo i miei adorati studi di filosofia. E lì, in trincea, tra l’intrecciarsi convulso dei dialetti di noi soldati, provenienti da ogni parte d’Italia, nell’angoscia e nello stridore di una vita spogliata della sua bellezza e della sua dignità, ho assaporato il bisogno di una vera e propria rinascita spirituale, che spazzasse via le incrostazioni e gli infingimenti dei falsi miti, delle irresponsabili pulsioni per la contingenza dell’effimero, per una gloria caratterizzata da vuotezza e inconsistenza, destinata a germogliare solo sul concime avariato della violenza e del disprezzo. Ho compreso, allora, che, se il dolore è ineliminabile dal nostro orizzonte vitale, tuttavia può essere lenito dalla consapevolezza del nostro cammino comune, che non richiede la vertigine gelida della protervia e dell’arroganza, ma il caldo respiro del riconoscimento dell’umanità che vive in ciascuno di noi, insofferente delle barriere e dei pregiudizi, degli steccati e dei risentimenti. La vita, la mia vita ha bisogno di “occhi nuovi”, che mi permettano di gettare uno sguardo trasparente sugli altri e sul mondo, sentendo il fiato degli esseri umani confuso con il mio, per vivere e morire assieme in questo mondo imperfetto ma animato dal fervore e dallo slancio di quella fragilissima e al tempo stesso portentosa canna pensante che è l’Uomo, come aveva mirabilmente compreso il mio amato Pascal. Per questo, forse, la vita mi circonda ancora delle sue premure, e non mi ha lasciato alle gelide spire della morte, perché potessi ritrovare nel volto degli altri la grandezza del pensiero e della volontà di amare di cui siamo dotati. Ricordo, riandando ai miei studi di filosofia greca, la profonda impressione in me suscitata dalla dottrina di Empedocle, che pone alla base della vicenda dell’universo le due forze cosmiche dell’Amore e dell’Odio, che si contendono la supremazia e danno vita alternativamente a cicli caratterizzati dalla prevalenza dell’armonia e dell’unione o invece del caos e della divisione. E allora, per noi uomini, unirci o confederarci significherebbe poter contrastare l’impulso distruttivo che ha preso il sopravvento in questo tempo storico ansimante e ricolmo di angoscia; ho appreso con sollievo che il presidente americano Wilson ha proposto la nascita di una Società delle Nazioni, il germe, forse, di un futuro governo mondiale, in cui tutti gli uomini possano finalmente riconoscersi e ritrovare il sentimento della solidarietà di destino che li unisce. Ma non voglio abbandonarmi alle grandi speranze, ora voglio soltanto dedicarmi alle piccole speranze: due giorni fa, il generale Diaz ha proclamato la vittoria dell’Italia e gli Imperi centrali sono sul punto di capitolare; la mia gamba martoriata probabilmente si salverà e le mie inquietudini affannate, i miei sonni agitati, i miei ricordi straziati si disporranno ad accogliere le lievi speranze della mite primavera, che subentrerà al triste inverno della natura e dell’anima, quando le nevi si scioglieranno e i torrenti torneranno a scorrere con la loro acqua cristallina, e io proverò a correre di nuovo sui prati in fiore, con i capelli scompigliati dall’alito benevolo del vento, chiedendo fiducioso alla mia anima dolente di pacificarsi con sé stessa e con il mondo…